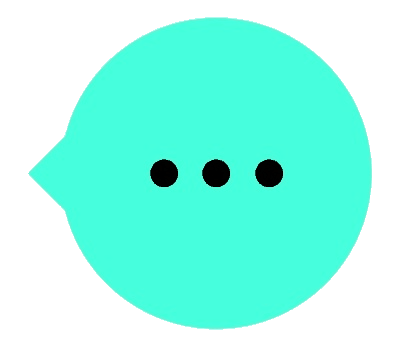Questo è uno di quegli articoli che non hai mai pensato di scrivere ma che nascono con estrema naturalezza, proprio mentre sei intento a scrivere tutt’altro. O perché la mente inizia a vagare o perché ricevi un input esterno, inizi un serendipico percorso che, nel mio caso, ha portato a chiedermi se la massima possibilità di personalizzazione che ci offrono oggi i vari canali e piattaforme, sia come consumatori che professionisti di marketing e comunicazione, abbia un risvolto negativo sulla società.
Per capirci meglio: oggi tutti noi abbiamo la possibilità di poterci creare un mondo tutto nostro all’interno di una grande realtà collettiva, che viene distorta a seconda dei filtri che utilizziamo. Un luogo fatto su misura per noi dove rifugiarci ogni volta che desideriamo, dove tutto è decisamente più “bello”. Anche le brutte notizie vengono raccontate da una prospettiva che ci appartiene e le pubblicità ci propongono sempre più prodotti o servizi che realmente ci interessano e nel momento giusto.
Diciamocelo, è una gran figata!
Soprattutto se facciamo un paragone con qualche anno fa, dove potevamo soltanto scegliere il giornale con il quale informarci, quale programma TV da palinsesto vedere in prima serata, quale radio o genere musicale ascoltare, di trasferirci al centro o in periferia oppure scegliere il tipo di vacanza che più gradivamo.
Senza dimenticare che, a differenza di oggi, in questo ecosistema eravamo abituati anche a usufruire di contenuti, ricevere informazioni e messaggi pubblicitari in modo forzato, subendo i processi senza esserne parte integrante. Eravamo insomma costretti a vedere e ascoltare anche cose che non ci interessavano ma che in un modo o nell’altro potessero ampliare la nostra visione o conoscenza. Cosa è cambiato quindi nel concreto?
Hai presente quella sensazione di terrore quando un amico, il tuo compagno o la tua collega ti chiede di poter cercare un video dal tuo Youtube o di utilizzare per la musica il tuo Spotify? Va meglio se ti chiedessero di scegliere un film che va contro la tua natura su Netflix o quando ti trovi a cercare e acquistare un regalo che non avresti mai comprato per te su Amazon?
Nessuno di noi vuole che Youtube ci consigli video che non ci interessano, che Spotify faccia partire il Daily Mix con “Gelato al cioccolato”, che Netflix sembri una scelta peggiore dello zapping alla TV o essere bombardati da Ads su Facebook e Instagram in merito a prodotti che ci mettono soltanto ansia.
Quello che è radicalmente cambiato, quindi, è la sicurezza e la certezza di avere sempre un’esperienza cucita su di noi e il pieno controllo sul cosa, dove, come e quando.
Siamo ciò che seguiamo e ci interessa?
Consapevoli o meno, pare che tutti noi siamo felici di far parte di cluster ben definiti perché questo, oggi, ci permette di essere circondati soltanto da ciò che ci interessa o da quello che reputiamo giusto, confermato da un’analisi di Rocket Fuel sulla percezione che hanno i consumatori dell’intelligenza artificiale applicata anche alla pubblicità, che ci mostra come l’80% dei millenials apprezza la pubblicità personalizzata (il 66% in Italia).
C’è una sorta di rapporto win-win tra consumatore, piattaforme, aziende e brand, dove il primo concede agli altri la possibilità di scoprire e conoscere i propri interessi e comportamenti per poter vivere appunto un’esperienza personalizzata.
Quello su cui però non riflettiamo è che se da un lato mostriamo e decidiamo cosa vogliamo vedere, automaticamente stiamo rinunciando ad altro. In questo modo ci escludiamo dalla possibilità di poter scoprire nuovi interessi e allontaniamo dalla nostra vita interi pezzi di realtà.
Così facendo, non facciamo altro che creare terreno fertile per il Confirmation Bias (Bias della Conferma), ovvero quel processo cognitivo automatizzato che ci porta a ricercare le informazioni che vanno a confermare la nostre ipotesi, respingendo o ignorando quelle che le contraddicono, con la conseguenza di escludere dalla propria visione ogni potenziale alternativa.
In poche parole, se non stiamo attenti rischiamo di costruirci una comfort zone davvero impenetrabile, con la conseguenza di diventare realmente quel cluster in cui ci hanno inserito, finendo per essere solamente ciò che seguiamo e ci interessa.
Chiunque lavori nel settore del marketing e della comunicazione è consapevole di come sia facile ormai raggiungere audience sempre più precise, di tutti i meccanismi che vengono innescati e della precisione dei dati che si possono raccogliere. E nonostante ciò, sta vivendo in prima persona, sia da fruitore che da professionista, il cambiamento nel modo di comunicare, pensare e interagire.
Da un lato, quindi, ci sono le persone (navigatori, utenti, iscritti, abbonati ecc) che stanno perdendo la connessione con la realtà mentre sono intenti a costruirsi un mondo su misura, eliminando in modo consapevole tutto ciò che credono non sia essere giusto o di loro interesse.
Dall’altro, c’è l’intera industria del marketing e della comunicazione che vede i vari protagonisti lavorare incessantemente per profilare e segmentare sempre meglio le audience così da ottimizzare i budget investiti e raggiungere maggiori risultati grazie a contenuti sempre più mirati, riducendo al minimo anche il rischio di innescare reazioni negative a causa di non coerenza o timing errato.
Il prodotto finale che ne deriva dalle azioni di questi due emisferi apparentemente opposti ma che spingono nella stessa direzione, è un sistema perfetto che si autoalimenta ma che produce come materia di scarto una polarizzazione tossica che avvelena la sana contaminazione.
Lasciando stare per un attimo l’eccezione negativa che il Covid ci ha fissato nella mente, la contaminazione sana è fondamentale perché ci permette di mettere in discussione i nostri punti fermi, ci dà la possibilità di confutarli, migliorarli o cambiarli. È la cura al “ho sempre fatto in questo modo”. È l’unica vera fonte di energia che porta a migliorarci e innovare.
L’effetto della polarizzazione tossica: l’intolleranza
Polarizzare è da sempre una diretta conseguenza oppure obiettivo prefissato della comunicazione: definire i cluster, individuare il target specifico e su di esso cucire l’intera strategia di marketing, comunicazione e pianificazione media è la prassi per ogni brand, azienda o politico. Farne a meno è impossibile, ma questo non vuol dire dover puntare alla polarizzazione per cercare il buzz mediatico ad ogni costo.
Infatti, ad alimentare questa polarizzazione ci sono stati diversi protagonisti, come i nuovi modelli di revenue degli editori (click bait), i leoni da tastiera, la classe politica, la disinformazione, la pandemia e il “cosa stai pensando” di Facebook, trovando terreno fertile in un contesto dove l’analfabetismo funzionale è al 27,9% e quello digitale al 79% (16- 65 anni dati OCSE).
In un contesto già grave di suo, dove la maggioranza degli utenti non sa come usare lo strumento e una buona parte non capisce neanche cosa sta leggendo, si manifesta sempre di più la necessità di fermarsi a commentare post organici e/o sponsorizzazioni, soltanto per dire che il prodotto non è di proprio interesse, offendere o rincarare la dose andando giù con offese o auguri per un imminente fallimento o addirittura la morte.
E lo si constata facilmente notando come l’utente medio si senta in diritto di dover dire la propria, soprattutto quando si è in disaccordo con la direzione dei post o dei commenti. Sono ormai decine e decine gli articoli che vengono pubblicati ogni giorno in merito al cyberbullismo e l’hate speech.
Possiamo dirlo apertamente: tutti percepiamo che c’è più intolleranza sui social media piuttosto che in tutte le sale d’attesa dei gastroenterologi italiani, cosa che sfocia in odio gratuito a diversi livelli di intensità.
È proprio in merito a quest argomento che ormai da qualche anno VOX, l’Osservatorio Italiano sui Diritti, in collaborazione con l’Università Statale di Milano, l’Università di Bari Aldo Moro, Sapienza – Università di Roma e IT’S TIME dell’Università Cattolica di Milano, redige la Mappa dell’intolleranza che è arrivata alla sua quinta edizione, sempre con l’obiettivo di rilevare i sentimenti che animano le communities online.
I Dati raccolti ci dicono che in generale “l’odio” diminuisce ma si radicalizza e nell’anno della pandemia si concentra contro le donne, soprattutto se lavorano, ebrei, musulmani, omosessuali, migranti e persone con disabilità.
Qui la mappatura completa.
In questo caso, VOX, mette al centro argomenti troppo importanti che vanno affrontati in altro contesto ma, questo diffuso comportamento che porta l’utente medio a commentare in modo aggressivo e offensivo mondi e contesti lontani, dei quali conosce effettivamente poco o niente, si manifesta anche su temi decisamente più leggeri.
Una forte intolleranza che sta iniziando a colpire anche quella minoranza che fino a poco fa preferiva tacere davanti all’ignoranza e la cattiveria, sentendosi in dovere e diritto di arginare questo fenomeno.
Atteggiamento sano fino a quando non si è totalmente pervasi dal politically correct, finendo per diventare iper critici anche in merito a oggettive buone notizie: un’azienda crea occupazione in luoghi economicamente depressi ma si punta il dito per la % di quote rosa nel management, oppure quando vengono raccolte ennemila euro per salvaguardare la biodiversità di un sito naturale e si critica perché nessuno sta pensando ai bambini con malattie rare.
E a proposito di tutto questo odio gratuito dal quale non si riesce a ricavare proprio nulla di buono, anche Amnesty con il suo barometro dell’odio ci fornisce una panoramica che conferma questo spiacevole fenomeno.
In sostanza, siamo circondati per lo più da persone che passano il proprio tempo a trovare un nemico da incolpare per i propri fallimenti, insuccessi o periodi bui piuttosto che analizzare se stessi per capire dove si è sbagliato e riconoscere i propri punti deboli, finendo ancora una volta per distorcere la realtà.
Come possiamo uscirne?
La lotta all’intolleranza è una sfida che chiunque si occupa o investe in comunicazione dovrebbe affrontare. Purtroppo è utopico pensare che si possa trovare un modo comune di agire visto quanto sono diverse le visioni e le modalità di moderazione all’interno delle aziende.
Basta pensare al fatto che, purtroppo, non è ancora così raro imbattersi nel “purché se ne parli”. E finché ci saranno brand e professionisti che pensano in questo modo, ci sarà ancora tanta strada da fare per l’industria del marketing e della comunicazione.
Cosa ancora più grave se si riflette sui dati elaborati dall’Osservatorio Civic Brands, il progetto editoriale e di ricerca di Ipsos e Paolo Iabichino che ha l’obiettivo di indagare e raccontare l’impatto reale che le azioni di aziende e brand hanno sulla società: le analisi dimostrano che il 39% del campione pensa che le aziende possano guidare il cambiamento, contro il 26% di chi crede nel governo, mentre il 13% indica i consumatori stessi. Tutto confermato dal fatto che proprio questi ultimi si aspettano dai brand cura e attenzione per i propri dipendenti (83%), che si facciano carico di temi sociali vicini (82%) e che prendano posizione e si schierino su questioni delicate (68%).
Insomma, combattere l’intolleranza sarà una delle sfide più importanti e difficili per i brand, soprattutto considerando le aspettative che hanno i consumatori nei loro confronti: il 43% degli intervistati ammette di non aver più acquistato prodotti e servizi dai brand che li hanno delusi. Per riuscirci, sarà necessario il supporto dell’intera filiera del marketing e della comunicazione che insieme devono porsi degli obiettivi e unirsi sotto nuovi principi.
Provando a riassumere quanto detto fino a questo momento, è necessario dunque che brand e aziende siano:
1. Coerenti: non basta più comunicare, ma rendere concreto lo storytelling sia per una questione etica generale sia per evitare di diventare il prossimo bersaglio sul quale concentrare tutta l’intolleranza. È ora di destinare energie per essere coerenti con ciò che si comunica e di impattare in modo positivo sulla società, di abbandonare gli slogan trendistici soltanto per cavalcare l’istant di turno e puntare prima a definire una propria identità e dargli forma e sostanza.
2. D’esempio: grazie alle peculiarità uniche dei canali digitali, i brand hanno instaurato un dialogo costante con il proprio target, diventando punti di riferimento dai quali ci si aspetta una presa di posizione. È ancora maggiore quindi l’impatto che ora i brand hanno sui modi di pensare e di agire attraverso il tono di voce e le scelte strategiche/commerciali adottate. Per combattere questo fenomeno è quindi necessario sentirsi responsabili e dare il corretto esempio, al pari di chi fa dell’educazione la propria professione.
3. Umani: ogni brand ha il suo target, del quale conosce tutte le peculiarità che permettono appunto di identificarlo come buyer persona. Nonostante le tante diversità, tutti i target hanno in comune una sola cosa: sono esseri umani. Dal momento in cui si smette di vederli come consumatori ma bensì come persone che affrontano problemi e preoccupazioni, vivono gioie ed esperienze e hanno diverse passioni e interessi, si può provare a impattare in modo serio sulla società. È questa visione che deve influenzare fortemente i piani editoriali, le strategie di contenuto e di prodotto.
I brand e le aziende hanno quindi una lunga e dura sfida da affrontare per rendere inclusiva e meno intollerante la società in cui viviamo, con tutti i rischi che chiunque si schieri in modo palese può incorrere. Ecco perché questa è una sfida che tutti noi come singoli dovremmo fare in parte nostra, partendo proprio dal seguire gli stessi principi.