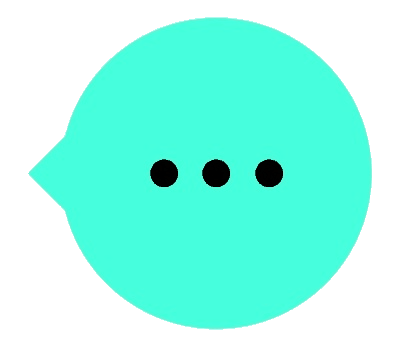Ambiente, diritti civili, uguaglianza sociale, in un modo o nell’altro, sono ormai temi sulla bocca e gli schermi di tutti.
La società si è evoluta e risulta esserci una sempre maggiore attenzione e sensibilità verso determinate questioni sociali e ambientali. Non solo da parte delle persone, ma anche dei brand.
Sono tantissime, infatti, le iniziative di comunicazione che oggi vengono messe in atto dalle aziende per sostenere cause sociali. Spesso si concentrano in giorni particolari, come l’8 marzo, nelle classiche Giornate Mondiali – tanto care ai social media manager – come l’Earth Day – o in periodi specifici dal forte significato, come il mese di giugno dedicato al Pride. Tuttavia, tra modelli in limited edition trapuntati di arcobaleni, il restyling di packaging in cartone riciclato e loghi avvolti da fiocchetti rosa, molte di queste iniziative non sono mosse da una motivazione reale. Piuttosto vengono intraprese dai brand per soddisfare un puro interesse economico e portare le persone a costruire un’immagine ingannevolmente positiva di sé.
È in questi casi che si parla di “brand washing”, un fenomeno tanto discusso quanto diffuso nella comunicazione di marca.
Brand washing qua, brand washing là, brand washing su, brand washing giù. Ma che vuol dire?
È un termine che deriva dal verbo inglese “whitewashing” (imbiancare, nascondere) e riguarda tutte quelle campagne pubblicitarie che sono apparentemente mosse a favore di cause sociali, ma che sostanzialmente vengono messe in atto per un unico obiettivo: incrementare i profitti aziendali.
Il brand washing è anche noto come woke washing, dal passato di “wake” – svegliarsi – in inglese. Fa riferimento a un improvviso risveglio della coscienza dei brand sull’importanza di mostrarsi vicini a particolari tematiche – oggetto di interesse e discussione pubblica – per il puro intento di far leva sulla sensibilità e i valori del proprio pubblico, ottenere like in più ai propri post e aumentare, così, le proprie vendite. Come una captatio benevolentiae, in pratica.
Quanto comunicano di sé, però, non è supportato da azioni concrete, anzi tante volte ciò che si racconta è l’esatto contrario di ciò che si fa realmente, o che si è fatto fino a poco prima. Molte aziende che decidono di costruire il proprio storytelling intorno a determinati valori e temi sociali sono, infatti, le stesse che, alle spalle, presentano una storia di violazioni di diritti o politiche aziendali controverse. E il loro intento non è altro che quello di “ripulirsi”, appunto, la coscienza dal loro – neanche troppo lontano – passato. Perlomeno stando a ciò che dicono. Per intenderci, il brand washing non è che l’equivalente del proverbio: predicare bene e razzolare male.

È brand washing quando…
- Le proprie affermazioni sono false o non presentano info o dati a supporto
- Una particolare caratteristica di un prodotto viene dichiarata come certificata, senza esserlo.
- Viene data enfasi a una sola caratteristica del prodotto, che può essere definita ad esempio come green, sorvolando su determinati aspetti della produzione che ridimensionerebbero il valore della caratteristica enfatizzata (i tuoi capi sono green, utilizzi packaging in carta riciclata, ma ometti che sfrutti migliaia di bambini ogni giorno per produrli)
- Le informazioni sono vaghe e creano confusione (“Le nostre box sono biodegradabili”. Anche la plastica è biodegradabile, peccato che impieghi secoli a farlo. Spiegati meglio.)
- Vengono utilizzate etichette false o contraffatte.
- Quando l’attenzione a quel tema specifico dura il solo momento del trend
Green, pink, rainbow washing. Ce n’è di tutti i colori.
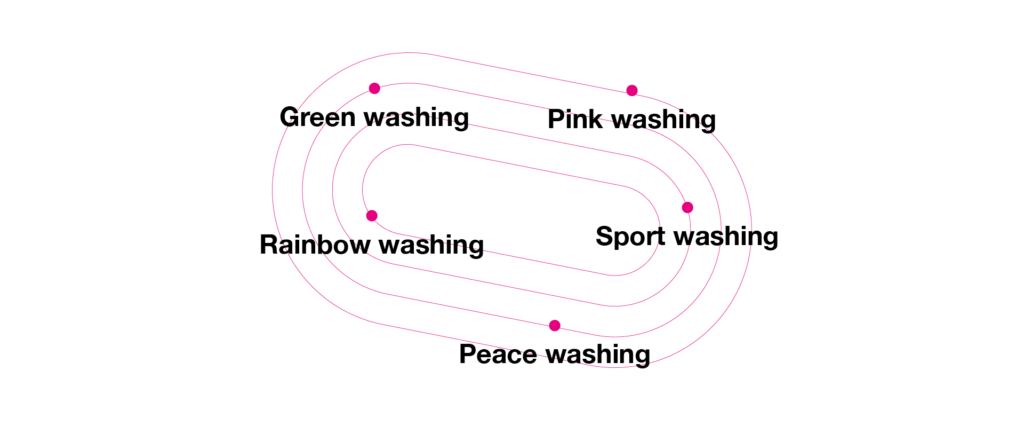
Il brand washing, o woke washing, ha tante sfumature, che aumentano nel tempo con la crescente sensibilità delle persone sulle questioni sociali e ambientali.
Lo si può definire una macro-categoria che, al suo interno, include fenomeni più noti.
Primo tra tutti il green washing, ovvero l’ecologismo o ambientalismo di facciata.
Si parla di greenwashing quando un brand vuole far credere al proprio pubblico che sta facendo molto di più per salvaguardare l’ambiente rispetto alla realtà. In pratica quando un potenziale cliente si rivolge a noi con la volontà di fare una campagna incentrata sulla sostenibilità, sul futuro, il cambiamento, senza avere nessuna informazione che dimostri quanto la sua azienda sia effettivamente sostenibile.
“Ci potete fornire qualche informazione in merito?”
Ghosting.
Ah.
E quindi il povero copywriter di turno (e qui mi includo), insieme a tutto il team, deve capire come fare per non perdere la faccia, affermando falsità per conto di altri, e per soddisfare, al tempo stesso, la richiesta del cliente. Il risultato, spoiler, non è mai nulla di buono.
Vi è poi il pinkwashing e si verifica quando un brand dichiara di sposare una causa femminista per promuovere un certo prodotto o servizio, senza fare azioni concrete in supporto alla causa. Il termine “pinkwashing” è stato utilizzato per la prima volta da Barbara Brenner, membro della Breast Cancer Association che promuove la lotta contro il cancro al seno, per denunciare tutte quelle campagne pubblicitarie di aziende, per lo più di cosmetica, che mercificano la causa con la promessa di sensibilizzare le donne sul tumore al seno. Non sono poche le aziende che avvolgono i pack dei propri prodotti con fiocchetti rosa per aumentare le proprie entrate, ma che poi non donano neanche l’1% dei propri ricavi alle associazioni realmente impegnate nella lotta. O ancora brand che citano grandi donne della storia nei propri piani editoriali per manifestare il proprio femminismo, ma che presentano un elevato gender gap all’interno della propria azienda.
E quando si parla di LQBTQIA+, il pink diventa rainbow washing. Un termine che ricorre soprattutto a giugno, nel mese del Pride, quando i feed si riempiono di sponsorizzate dei brand con promo e special edition dalle tinte arcobaleno, mentre nelle associazioni nessuno li vede e nessuno li sente.
Lo sportwashing fa invece riferimento all’investimento da parte di un determinato Stato in iniziative sportive volte ad ammodernare l’immagine di quel dato Paese e a distogliere l’attenzione da violazioni di diritti umani e civili. A questo proposito, non si può non pensare ai Mondiali di calcio in Qatar.Tra le forme di brand washing, si parla anche di peacewashing con riferimento alle iniziative messe in atto dai brand contro il razzismo e la guerra. Nonostante il marketing, storicamente, abbia sempre cercato di tenersi lontano dalla politica e da temi drammatici, da dopo l’omicidio di George Floyd e le proteste del movimento Black Lives Matter, si è ritenuto che fosse necessario per i brand prendere posizione, ma soprattutto che fosse pericoloso non prenderla. Ancor di più a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina. In alcuni casi, un messaggio di vicinanza sui social e i colori della bandiera ucraina applicati sul logo sono bastati a dare fiducia ai consumatori sul sostegno dei brand nei confronti del Paese, in altri casi questo tipo di azioni formali ha spinto i clienti a chiedersi cosa, in effetti, quei brand stessero realmente facendo a sostegno dell’Ucraina. Esempio lampante è il caso Nestlé: se da una parte il brand ha pubblicato post in supporto al Paese governato da Zelensky, dall’altra la multinazionale è divenuto oggetto di un vero e proprio boicottaggio da parte dei consumatori, perché rifiutatasi di abbandonare il mercato russo.
Di esempi di brand washing ce ne sono tanti, anche troppi. Qui ce ne sono alcuni.

Ricorderai sicuramente l’affermazione di Guido Barilla nei confronti della comunità LGBTQIA+ e tutta la bufera mediatica che scatenò su di lui e sulla sua azienda.
“Non faremo pubblicità con omosessuali perché a noi piace la famiglia tradizionale. Se i gay non sono d’accordo, possono sempre mangiare la pasta di un’altra marca”.
Bene. Dopo aver preso brutalmente le distanze dal tema dei diritti arcobaleno, la posizione del brand pare sia stata poi opportunamente rivista: sarà stato per un improvviso cambio di opinione in merito, o per una chiara strategia di rainbow washing? Chissà. Fatto sta che oggi Barilla si colloca ai primi posti nella classifica del Corporate Equality Index stilato ogni anno dalla Human Right Campaign – l’associazione per i diritti LGBTQIA+ – e volto a misurare la crescita di politiche, misure e benefit aziendali a favore della comunità.
C’è poi il caso di Pepsi che ha dovuto ritirare lo spot con Kendall Jenner a sostegno delle proteste Black Lives Matter. Nel commercial, la modella Kardashian è alle prese con un servizio fotografico quando sente il vociare di un corteo pacifista, lo interrompe e offre una Pepsi alle forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa, per invitarle a raffreddare gli animi e a godersi un #Pepsimoment – hashtag della campagna. Il brand è stato accusato di aver usato con semplicismo e per puro interesse economico gli slogan e i simboli del movimento pacifista degli anni 60, e di questo ha poi dovuto chiedere pubblicamente scusa.
Altro esempio significativo di woke washing è L’Oréal, che ha deciso di eliminare dalle etichette dei propri prodotti termini come “sbiancante” o “schiarente” in segno di vicinanza alla Black community. Operazione puramente di facciata, se pensiamo che poco tempo prima l’azienda aveva messo fine a collaborazioni con alcuni testimonial poiché sostenitori del movimento Black Lives Matter.
Nel mirino anche la Mattel, casa di produzione della Barbie, che è stata accusata di utilizzare a proprio vantaggio il tema della body positivity, dell’inclusione e della promozione di canoni di bellezza non tradizionali quando ha lanciato la Barbie nera, curvy, in sedia a rotelle, ungendered. Dopo aver promosso per anni e anni stereotipi sulla femminilità e una certa visione della bellezza e della sensualità, il suo improvviso cambio di rotta, con la nuova linea di Barbie, non poteva che risultare poco credibile e mosso puramente da un desiderio di profitto.
Un’accusa molto simile è stata rivolta anche a Gillette e in particolare a campagne come “It takes a real man” di Gillette Spagna, incentrate sulla lotta alla mascolinità tossica e sul promuovere una nuova idea di mascolinità, distante da stereotipi di genere come quello che “i veri uomini non piangono”. Per molti, queste azioni comunicative sono solo una mossa maldestra di avvicinarsi alle nuove generazioni da parte di un brand che per decenni ha dato valore alla cultura del “maschio alpha” e che, per altro, ancora adesso in Italia si presenta con testimonial e claim piuttosto machisti, che affermano che “i veri uomini” si dividono tra “bomber” e “king”.
Non è un caso che queste campagne stiano sbucando tutte nello stesso periodo. Brand che fino a un istante fa non hanno mai detto una parola su un certo tema, improvvisamente lanciano hashtag campaign, iniziative di corporate social responsibility incentrate su quel tema, solo perché divenuto caldo – magari a seguito di un episodio o una protesta di risonanza internazionale – come lo sono diventate le discriminazioni razziali dopo la morte di George Floyd e le proteste del Black Lives Matter in America, o come lo diventano puntualmente i diritti civili ogni anno a giugno, il mese dedicato al Pride.
Tanti fanno brand washing, ma a che pro? E soprattutto, con quali contro?

Tante aziende stanno investendo in iniziative di tipo ambientale e sociale con l’intento di migliorare la propria brand reputation, ma anche per accrescere e fidelizzare la propria community così da aumentare i ricavi nel medio e lungo termine. E ciò che all’esterno può sembrare una forma di attivismo vivace da parte loro, in realtà in molti casi è un mero tentativo di cavalcare il tema del momento, di farsi sentire e quindi vedere. Altre volte, invece, sostenere una causa diventa un modo per riparare a condotte eticamente e socialmente poco accettabili ed “uscirne puliti”.
In un modo o nell’altro, il brand washing è visto dalle aziende come una strategia di comunicazione redditizia. Questa strategia, però, oltre ai suoi vantaggi, porta con sè anche diversi svantaggi, che è importante analizzare per capire se, e eventualmente in che misura, valga la pena metterla in atto.
I vantaggi sono principalmente tre:
- Ritorno economico: le vendite aumentano perché i prodotti/servizi del brand acquisiscono un valore etico;
- Miglioramento della brand reputation: le aziende che si mostrano aperte e inclusive hanno un riscontro positivo sulla propria reputazione;
- Crescita della propria community e dei propri clienti: con queste iniziative, i brand si rivolgono ad uno specifico pubblico, sensibile ai temi supportati. Queste persone sceglieranno tali brand impegnati socialmente; di conseguenza, il loro numero di clienti tenderà ad aumentare.
A ben vedere, questi tre vantaggi non possono che far gola alle aziende, che si vedono a un passo da tutti i loro principali obiettivi. Ma come ci insegnano le migliori favole, se i tre desideri possono essere esauditi, questo vuol dire che l’inganno è dietro l’angolo.
Queste iniziative, infatti, si possono ritorcere contro il brand come un boomerang e il rischio più alto è quello di andare incontro ad un boicottaggio da parte dei consumatori, oggi sempre più diffidenti rispetto alle iniziative di un certo brand. Questi capiscono subito se l’impegno del brand è reale o se il suo unico scopo è il profitto. E soprattutto, non dimenticano.
D’altronde, con l’attenzione che oggi i media rivolgono alle azioni messe in atto dalle aziende, è impensabile per i brand non farsi “sgamare”. Bugie e segreti hanno le gambe corte. E quando vengono fuori, hanno dei costi e delle conseguenze notevoli.
Il brand perderebbe credibilità e i consumatori potrebbero cominciare a non fidarsi più dei suoi messaggi positivi, anche quando veritieri, svuotando così il reale impegno di alcuni brand di ogni significato. Inoltre, questa sfiducia potrebbe portarli ad allontanarsi del tutto dal supportare una certa causa.
Sicuramente, poi, occorre trovare un buon community manager che sia capace di gestire la furia sui social, ma soprattutto mettere in atto un piano interventistico di crisis management per salvare la propria reputazione ormai compromessa. Tenendo conto del fatto che è complicatissimo portare le persone a cambiare la propria opinione, soprattutto se negativa.
Nonostante gli appetitosi vantaggi, quindi, in Ribrain consigliamo di evitare una strategia di brand washing innanzitutto perché moralmente sbagliata, ma anche perché del tutto controproducente.
Tra le reali iniziative di CSR e il brand washing c’è una linea molto sottile. Di contro, per evitare che il tuo attivismo venga percepito come opportunistico e fittizio, ti bastano poche accortezze.
Come puoi evitare di finire nel vortice del brand washing
- Comunica solo quello in cui credi realmente, e ricorda: le battaglie per i diritti civili e per l’ambiente non sono trend, sono una cosa seria, e vanno affrontate con convinzione, serietà e rispetto.
- Assicurati che la causa che vuoi sostenere sia coerente con la tua storia, i tuoi valori, la tua mission e con le tue azioni passate.
- Sii chiaro e trasparente rispetto ai motivi per cui hai scelto di sostenere una certa causa piuttosto che altre, soprattutto se la tua iniziativa implica una raccolta fondi o una donazione.
- Valuta bene i rischi di una certa azione: potrebbe non piacere a una parte del tuo pubblico; nel momento in cui vuoi supportare una particolare tematica, considera – soprattutto se sei una piccola realtà – che potresti scontentare, o addirittura perdere, una fetta dei tuoi clienti che magari la vedono diversamente su quello specifico tema.
- Affianca le tue parole ai fatti: prima di comunicare qualsiasi cosa, chiediti sempre “che contributo sto dando concretamente a questa causa?”
- Investi sul community management e sul crisis management: prendere parte a una questione controversa può portare a un risentimento, spesso seguito da un boicottaggio, da parte di alcuni consumatori. Dovrai essere pronto a gestirli.
Impara dagli errori degli altri, ma anche dai buoni esempi. Come le B Corp (di cui fanno parte Patagonia, Save the duck, Acbc e tante altre grandi aziende): realtà che si impegnano a rispettare un certo tipo di standard per avere un impatto positivo sul benessere dei propri dipendenti, sulla società e sull’ambiente, a favore di un’economia equa, inclusiva e rigenerativa.
Conclusioni? Più che sul brand washing, punta sul purpose-marketing.

Analizzare un fenomeno come il brand washing ci mette di fronte a un imprescindibile assioma:
Prendere una posizione oggi è importante e quanto mai necessario, ma le parole vanno accompagnate dai fatti.
Non basta soltanto pronunciarsi rispetto a una certa questione pubblica, ma sostenere quanto si comunica con delle azioni concrete e, quando necessario, supportare queste ultime con analisi, dati e numeri specifici. Le belle parole lasciano il tempo che trovano, ed è una copywriter a dirlo.
I consumatori di oggi, soprattutto i millennials e i giovani della gen z, sono sempre più informati e sensibili. Apprezzano l’autenticità, fanno attenzione a come mission e valori di una certo brand si avvicinino alla propria visione del mondo, e sono disposti a cambiare le proprie abitudini a favore di alternative etiche e più sostenibili, anche se più costose. Di contro, boicottano chi non agisce in merito a tematiche importanti. E di questo le aziende sono coscienti.
A fronte di questa consapevolezza, i brand sono chiamati a mettere in atto un cambiamento nella propria strategia aziendale e a rendere i propri pubblici parte di una sfida, di un purpose: un obiettivo che nasce da una motivazione profonda e va al di là del profitto, al quale le persone possano legarsi emotivamente.
Investire sul proprio purpose porta il brand a differenziarsi e a creare un sentimento di fiducia e appartenenza nei propri pubblici, i quali si sentono parte di un progetto più grande e in cui credono.
Come fare per dar vita a una purpose-strategy?
1. C’è bisogno innanzitutto che tu abbia chiara la ragion d’essere della tua azienda e il valore che vuoi portare al mondo con essa. In altre parole, trova il tuo perché.
2. Definito il tuo scopo ultimo, vai a definire i come – le azioni da compiere per intraprendere il tuo progetto – e i cosa, ovvero vai a promuovere e diffondere il tuo progetto e le tue iniziative attraverso la comunicazione e la pubblicità.
3. Quando è arrivato il momento di comunicare il tuo purpose, ricordati di farlo sempre in modo onesto e etico, supportando le tue parole con azioni concrete, per evitare di cadere nel brand washing.
E se hai bisogno di una consulenza, non esitare a contattarci.